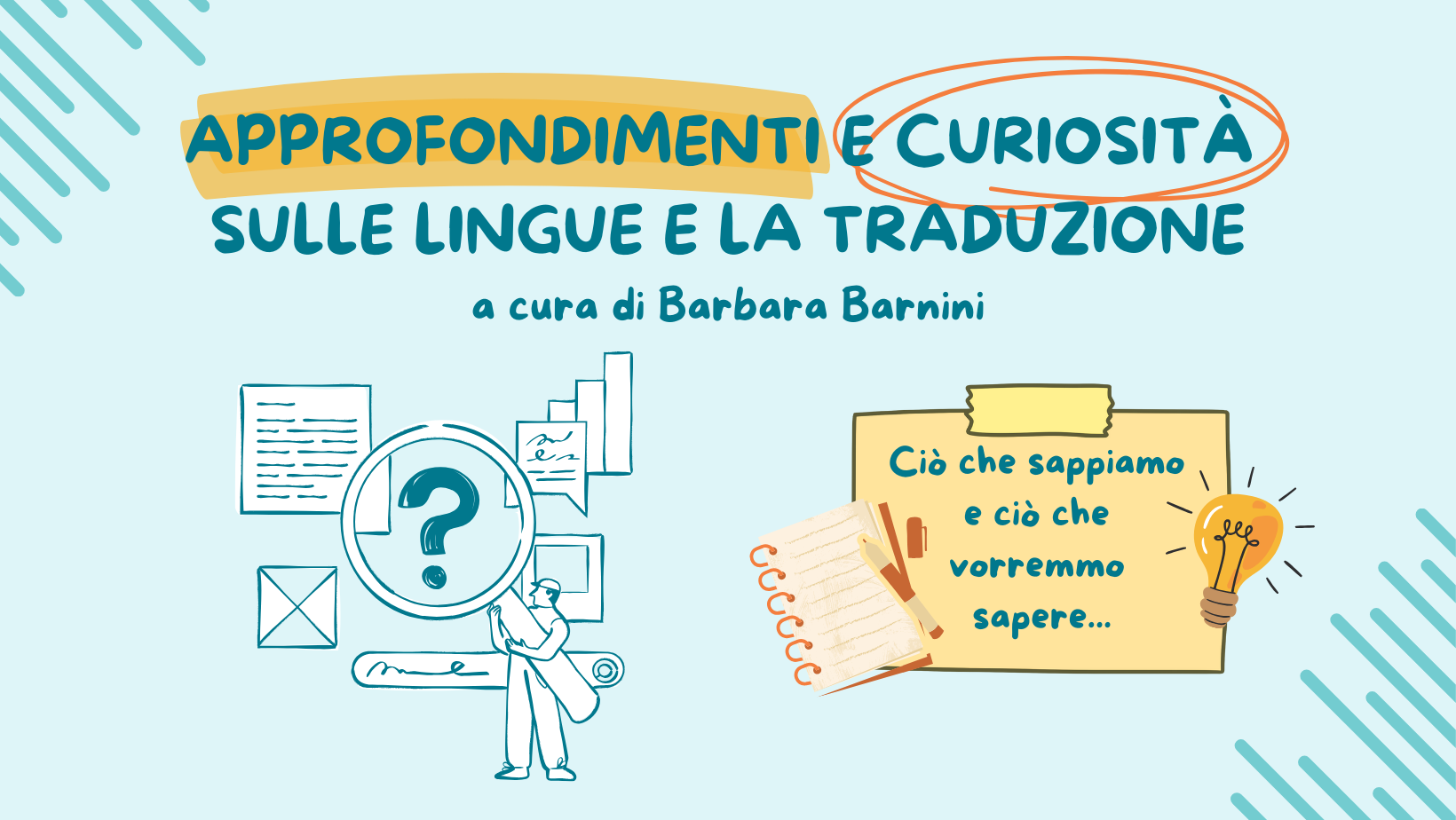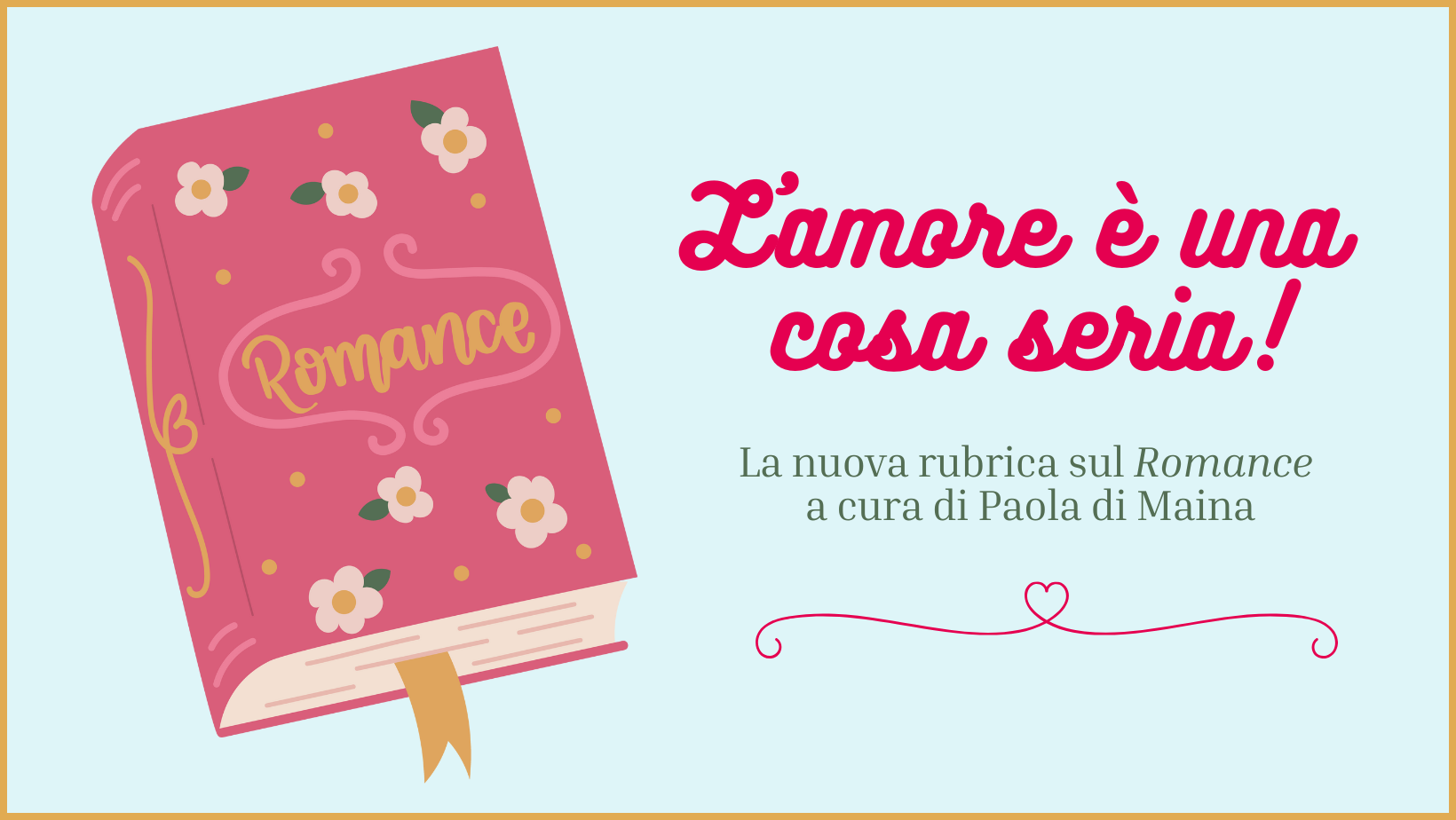Lusofoniamo: Manuel Bandeira, tra malinconia e tenerezza
Apro la finestra, la luce si declina e la pioggia si propone come compagna per i prossimi giorni. Sembra che questa atmosfera sia arrivata di proposito per obbligarci a prendere una pausa, magari per leggere o rileggere, ricordare.
Passo le dita sugli scaffali polverosi della libreria e incontro la poesia di Manuel Bandeira. La sua voce cruda, segnata dalla malattia e dalla consapevolezza della morte, ha saputo sfruttare la fragilità umana per creare un canto di tenerezza e dalla malinconia ha plasmato una forma di bellezza.
Manuel Carneiro de Sousa Bandeira Filho nasce a Recife, nello Stato di Pernambuco, il 19 aprile 1886. Figlio di un ingegnere e di una donna dalla forte sensibilità, trascorre l’infanzia tra Recife e Rio de Janeiro. Studia al Colégio Pedro II e successivamente tenta di intraprendere gli studi di architettura a São Paulo, ma la diagnosi di tubercolosi lo costringe ad abbandonarli. Dal 1913 al 1914 vive in un sanatorio a Clavadel, in Svizzera, esperienza che segna profondamente la sua poetica.
Ciò che apparentemente può sembrare una condanna a morte si trasforma in una occasione di introspezione: il tempo sospeso della malattia diviene terreno fertile per far fiorire la sua poesia.
Il suo primo libro, A Cinza das Horas (1917), rivela tracce della tradizione parnassiana e simbolista. L’anno seguente pubblica Carnaval. A poco a poco Bandeira aderisce al Modernismo, lasciandosi alle spalle le rigidità metriche e aprendosi a una lingua libera da vincoli e più colloquiale. Nei suoi continui spostamenti, crea stretti legami con personalità del calibro di João Ribeiro, Mario de Andrade e Carlos Drummond de Andrade. Professore di letteratura, critico e traduttore, entra nel 1940 all’Academia Brasileira de Letras e ne diverrà il terzo occupante della ventiquattresima cattedra. Non abbandona la sua vena poetica e pubblica Poesias Completas con l’inclusione di Lira dos Cinquent’ Anos e Noçoes de Historia das Literaturas e, sulla Revista do Brasil, A Autoria das Cartas Chilenas. Si occupa anche di critica d’arte presso la testata A Manha di Rio de Janeiro. Nel 1956, traduce Macbeth di Shakespeare e La Machine Infernale di Jean Cocteau. Per la casa editrice El Ateneo, scrive le biografie di Gonçalves Dias, Alvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Junqueira Freire e Castro Alves. Come in una sorta di giostra che non si ferma mai, Manuel Bandeira scrive, traduce e pubblica ogni genere testuale fino alla fine dei suoi giorni.
Muore a Rio de Janeiro il 13 ottobre 1968 all’Ospedale Samaritano di Botafogo, lasciando come testamento poetico la raccolta Estrela da vida inteira.
Tra le sue poesie di esordio, in Cinza das horas spicca − la mia preferita − intitolata Cartas de meu avô.
Il testo nasce dal semplice e delicato gesto di leggere, sossegado e só, una lettera del nonno alla moglie; fermo immagine della loro vita, in un pomeriggio di pioggia. La scena è intima, raccolta, scandita dall’infinito ritmo regolare, monotono, delle gocce:
A chuva, em gotas glaciais,
Chora monotonamente…
L’io lirico, mentre legge si confronta con un amore forte e duraturo, che resiste al tempo e al declino, misurando la distanza con la propria fragilità:
E eu bendigo, envergonhado,
Esse amor, avô do meu…
Do meu – fruto sem cuidado
Que ainda verde apodreceu.
C’è ammirazione e allo stesso tempo vergogna: da un lato il piacere, deleite, per le solide radici di un amore che matura senza consumarsi, dall’altro la malinconia di non sentirsi all’altezza. Eppure, in questo scenario triste, si apre un lampo di tenerezza:
Eternecido sorrio
Do fervor desses carinhos:
É que os conheci velhinhos
Quando o fogo era já frio.
È un sorriso che spezza la monotonia, calore umano, un attimo di luce che ricorda come anche nel tempo che scorre inesorabile possa emergere la bellezza.